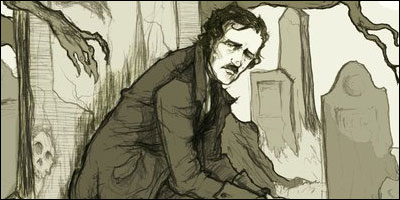Dei cinque racconti presenti ne “I mostri di Cthulhu”, quello che più rimane impresso nella mente è “L’ombra su Innsmouth”, ambientato in un New England che è al tempo stesso immaginario e reale, nel quale si svolgono scambi “commerciali” con i mostri al servizio delle divinità. Horror, fantascienza, addirittura fantapolitica (nella parte iniziale) si fondono nello spazio di circa ottanta pagine, nella descrizione di una fuga da un pericolo immediato, ma anche da ricordi spaventosi, incancellabili, che porteranno il protagonista alla pazzia. Ciò che più colpisce della scrittura di Lovecraft è come egli sia riuscito ad andare oltre i risultati raggiunti da Poe. Mentre le opere di quest’ultimo descrivono (in modo magistrale, è chiaro) un terrore fisico, il primo è in grado di offrire la rappresentazione di un terrore cosmico, ovvero delle radici dell’angoscia esistenziale dell’uomo. Le orribili divinità da lui create sono proiezioni di orrori interiori, quindi la paura per loro è in realtà la paura di noi stessi, dell’uomo in quanto tale, il vero “mostro” che Lovecraft cerca di descrivere. Così, se “Dagon” e “Nyarlathotep”, i primi due racconti, hanno il solo scopo di introdurre la teogonia lovecraftiana, è nell’ultimo racconto, “L’abitatore del buio”, che lo scrittore si confronta con i mostri che nascono e vivono nel profondo umano. Questi, tuttavia, non sono invincibili, anzi, esistono delle formule grazie alle quali possono essere controllati, racchiuse in un libro, il Necronomicon, realizzato da un uomo che, con lo spirito dello studioso, ha affrontato le sue paure, identificandone “le intrinseche debolezze, fornendo il sistema per dominarle, attraverso quei due potenti mezzi che sono la cultura e la fantasia”