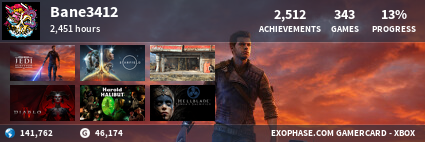Mi scuso in anticipo per lunghezza dell’iter argomentativo che vi propongo, ma davvero non trovo modo di arrivare al cuore della questione se non partendo da molto lontano.
Il cuore di ogni videogioco è il suo game design, ossia il set di regole che l’autore/team pone alla base del funzionamento e dello svolgimento del gioco.
Il game design determina anche tutto ciò che comunica con le regole del gioco, dalle specifiche scelte estetiche, passando per quelle sonore, a quelle narrative.
Con riferimento alla narrativa, abbiano giochi dove il costrutto narrativo è del tutto subordinato allo svolgimento del gameplay (Super Mario, Castlevania, Doom, Devil May Cry, ecc.).
Ci sono giochi dove allo svolgimento di un gameplay strutturato come nei casi suelencati si affianca l’esigenza di raccontare una storia complessa, basata su di una sceneggiatura più o meno strutturata.
Tra questi alcuni preferiscono dedicare lo svolgimento del plot a momenti passivi, le cutscens, come Metal Gear Solid o Soul Reaver.
Altri giochi preferiscono lasciare in mano al giocatore il controllo del pg anche durante lo svolgimento del plot, come Half-Life 1 e 2, che pur presentano possibilità di interazione con spazio e NPC in grado di generare micro-momenti di narrativa “emergente”, cioè micro accadimenti figli delle interazioni/reazioni degli elementi a schermo (esempio: farsi scortare da uno scienziato in Black Mesa e vederlo morire nella stanza X piuttosto che nella stanza Y è un mini-evento narrativo del tutto figlio del gameplay e diverso da giocatore a giocatore in base a come si è giocato quel determinato livello).
Abbiamo giochi ancora focalizzati sul gameplay dove lo svolgimento del plot è minimo, ma vi è una complessa backstory da scoprire giocando un po’ a fare gli archeologi (come la trilogia di Metroid Prime, Demon’s Souls, Dark Souls e Bloodborne, giusto per citare i più famosi ed emblematici esempi).
Ci sono giochi dove la narrativa diventa parte del gameplay perché si gioca con i dialoghi, si prendono scelte, si formano alleanze ed allineamenti morali, e magari vi è anche tanta backstory (lore se preferite) da scoprire. Tutto ciò accade negli immersive sim (Deus Ex, Dishonored) o in RPG a tutto tondo come Baldur’s Gate o la più recente saga di The Witcher.
E poi c’è tutta una schiera di giochi dove l’interazione è del tutto funzionale a raccontare qualcosa; giochi così diversi tra loro da aver dato vita ad una molteplicità di sub etichette giornalistiche. Laser games (Dragon’s Lair e affini), ibridi tra avventure grafiche e laser games (come i lavori Quantic Dream o quelli di Telltale, per limitarmi, anche in questo caso, agli esempi più noti), trial and error dal vibe cinematografico come Another World, walking simulator (Journey, Dear Esther, The Stanely Parable, Virginia, ecc.), ecc.
Questo mare magnum, in cui l’interazione, intesa come partecipazione attiva del giocatore nello svolgimento del gioco, inevitabilmente da adito a preferenze soggettive e a diatribe su cosa debba o meno essere considerato un videogioco e su cosa, tra i videogiochi, possa essere considerato un buon videogioco.
A mio personalissimo avviso, la flessibilità del “contenitore” videogioco è solo un merito di questo immenso medium in costante espansione grazie alla crescita del mercato e ai sempre più sconfinati spazi di sperimentazione. Credo che a fare la differenza sia sempre il “contenuto”, ossia quanto e come quel contenitore viene di volta in volta riempito con un game design capace di forgiare un’esperienza videoludica intelligente, ammirevole dal punto di vista della creatività e dell’ingegno umano profuso in essa.
Nel 2001, sulla sempre più sconfinata scena videoludica, si affaccia un’ulteriore e personalissima visione del videogioco a funzione prettamente narrativa, quella di Fumito Ueda e del team Ico, incarnata dall’omonimo gioco pubblicato su PS2.
Ico non è un gioco universalmente apprezzabile, perché difficilmente mette d’accordo incondizionatamente coloro i quali si riconoscono in una visione del videogioco piuttosto che in un’altra tra le categorie suelencate. La coperta è corta: la spinta su un fronte lascia il fianco scoperto a disappunto su altro fronte.
Eppure Ico è stato un gioco che definirei senza mezzi termini epocale. Le sue caratteristiche, gradite o meno che siano, hanno obiettivamente segnato un prima e un dopo.
Il minimalismo ludico di Fumito Ueda, da intendersi come set di meccaniche ridotto all’essenziale, così intuitive da non necessitare di HUD, è stato di ispirazione per molti aspiranti designers, specialmente tra quelli indipendenti, costretti dai limiti di budget alla creazione di gameplay minimali.
Le animazioni certosine di Ico e Yorda, atte a caratterizzare i pg come fossero corpi umani, mossi da fermezza e determinazione (Ico), insicurezza e fragilità (Yorda), diversamente reattivi in base ai diversi spazi attraversati, erano un qualcosa di diametralmente diverso dai freddi robot da esecuzione (perfetti per carità) suoi contemporanei, quali Tidus (FFX), Raziel (SR2) e Samanosuke (Onimusha). La responsività non era un problema, essendo Ico un gioco non prestazionale, non necessitante di esecuzioni perfette e che perciò ben poteva indugiare in orpelli estetici senza compromettere lo svolgimento del gioco. L’insegnamento di quelle animazioni ancora oggi riverbera in corpi caratterizzati da molte animazioni contestuali, atte a rendere palpabile e credibile la scena, da Nathan Drake (Uncharted saga) a Noctis Lucis Caelum (Final Fantasy XV).
La tridimensionalità concettuale del Castello di Ico, era un qualcosa senza precedenti: l’avanzamento portava ad un progressivo disvelamento dell’ambientazione, coerente, per cui ad ogni passo il giocatore avrebbe potuto capire la sua collocazione nel castello, facendo appello a questo o quell’elemento di riferimento, sempre visibile in lontananza (su tutti il cancello). Un qualcosa con quella resa e consistenza spaziale era senza senza precedenti, ed è un qualcosa che ancora oggi riviviamo in altri giochi. Non solo in giochi story driven, ma anche in mondi metroidiani come quello del primo Dark Souls o nel mondo realmente aperto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Ma soprattutto, Ico era il gioco che raccontava un rapporto, quello tra Ico e Yorda, facendo affidamento prevalentemente sul suo minimalista set di regole ludiche, e solo marginalmente con cutscenes. Un qualcosa che avrebbe avuto risonanza in tutto il mercato dei videogiochi: da tripla A quali Resident Evil 4 ad Enslaved, passando per The Last of Us e Bioshock Infinite, fino a creare nel mondo dello sviluppo medium-low budget una vera e propria schiera di “figli di Ico”, quali Brothers: Tale of Two Sons, Papa and Yo, Majin and the Forsaken Kingdom, Never Alone, ecc. Non tutti chiaramente hanno interpretato al meglio questo insegnamento, ma questa è un’altra storia.
Ico non ha cambiato solo la scena videoludica, ha ovviamente anche segnato l’inizio del personalissimo percorso tematico di Fumito Ueda.
Ico rappresenta e racconta a mezzo del linguaggio V-I-D-E-O L-U-D-I-C-O l’instaurazione di un rapporto umano tra due figure molto diverse tra loro e, per motivi diversi, prigioniere. L’epilogo è ambiguo e motivo di riflessione ed interpretazione.
Shadow of the Colossus prende le mosse dai temi portanti di Ico e mostra dove può arrivare un uomo quando un intenso rapporto umano, quello tra Wander e Mono, viene troncato. La rottura di un rapporto in SOTC è il presupposto per l’instaurazione di un altro rapporto, questa volta di tipo dialettico, tra uomo e natura.
In SOTC, senza andare troppo per il sottile, siamo noi il cattivo: si sconfina in una terra proibita, si violano le leggi dell’uomo e della natura per sconfiggere l’evento più naturale ed inevitabile che esista, ossia la morte, nella disperata impresa di restituire Mono alla vita.
Per farlo, si invade il bello, si è distruttori e assassini della magnificenza della natura incarnata dai Colossi. La regia sottolinea il dramma e la tensione di questa epica parabola discendente: ad ogni uccisione Wander appare più consumato, più intriso di oscurità.
Laddove in Ico l’instaurazione di un rapporto umano aveva impedito la rinascita del male (la Regina nel corpo di Yorda), in SOTC la distruzione di un rapporto naturalistico dai toni sacrali è la causa scatenante della liberazione del male (Dormin nel corpo di Wander), limitata in extremis dall’intervento sanzionatorio delle leggi dell’uomo (i sacerdoti che effettuato il rituale contro Wander-Dormin).
Non c’è vittoria alla fine di SOTC, solo una flebile speranza.
The Last Guardian, in veste di seguito tematico (non cronologico) di SOTC, trova la sua premessa nell’esigenza di ricomporre quel rapporto uomo-natura che avevamo distrutto nel precedente gioco.
Costruzione (Ico) -> Distruzione (Shadow of the Colossus) -> Ricomposizione (The Last Guardian).
Ancora una volta il compito è nelle mani del giocatore. Ancora una volta, il concreto atteggiarsi del rapporto è affidato all’interazione.
Si edifica un rapporto, come in Ico, ma stavolta lo si fa interagendo con un Colosso, anzi, con una creatura che è la summa di molti esseri presenti in natura. Le illustrazioni che si susseguono nella magnifica opening non lasciano adito a dubbi: Trico incarna, simbolicamente, quella natura verso cui dovrà tendere il nostro gesto riconciliatore.
Un’altra fuga dalla prigionia, ma questa volta siamo nel 2017; e per quanto Ico fosse affascinante come concetto, si trattava pur sempre di un gioco di fare salti non troppo complicati, di spostare casse e tirare leve. Tutti meccanismi già abbondantemente abusati, in una forma quasi sempre più smagliante ed approfondita in molti adventure della generazione PSX/N64.
Replicarsi non può bastare. E se, in ottemperanza al minimalismo Uediano, il team di sviluppo non può vincere la battaglia della creatività sul piano della complessità, non resta che provare a farlo sul piano dell’innovazione e della diversità.
Trico offre l’assist perfetto.
L’idea di Ueda è stata quella di fare un gioco che raccontasse e facesse vivere sulla pelle dei giocatori il disagio di dover collaborare con una bestia inizialmente ostile.
Nei panni del bambino siamo un po’ Ico e un po’ Yorda. Trico stesso è a tratti un po’ Ico e un po’ Yorda. L’uno apre la via all’altro e viceversa. L’uno protegge l’altro dai nemici e viceversa. L’assistenza è reciproca e talvolta concomitante, ma la costruzione delle situazioni germoglia poco alla volta.
Nelle fasi iniziali, in cui i comandi base vengono suggeriti insistentemente a schermo, il punto del gioco è capire come relazionarci ad un livello basilare con la bestia, arrivando ad usare correttamente le gestures eseguibili combinando i tasti base.
Non esiste unlocking delle gestures, queste sono tutte disponibili fin dall’inizio. Capirle ed usarle correttamente da subito presuppone che il giocatore abbia indagato e capito l’IA che governa Trico e come questa reagisce alle sollecitazioni. Ed occorre che il giocatore sia sicuro del proprio operato, se del caso spammando insistentemente la gesture che ritiene corretta per convincere il riluttante Trico.
Spammare invece gestures a caso equivale a giocare male TLG, perché la lenta reazione di Trico viene resettata da un’altra indicazione, e la reazione successiva da un’altra indicazione ancora, e così via, lasciando di fatto Trico perplesso per sostituzione di comando (magari esatto) con un altro.
Non è estremo e radicale come un pet simulator, ma un minimo di comprensione della natura animale è richiesto, e con essa un minimo di pazienza e reale voglia di vedere come questa curata creatura digitale risponde ai nostri stimoli.
Quindi è necessario innanzitutto hintare a Trico gli spazi giusti. Il bambino in questo contesto diventa una sorta di puntatore, il cursore di un’avventura grafica ma in un corpo umano.
“There are mouse-based games where characters follow the clicks performed by the player. My initial thought was to create a game where the mouse cursor is a boy in 3D space…Instead of thinking of the boy as the main character and Trico just as a gameplay tool, I think of the game as how to drive forward together with Trico.” Cit. Fumito Ueda
Inoltre, Trico non è un robot asettico, non è un mero “gameplay tool” e pertanto non esegue sempre necessariamente a comando, ma il giocatore deve credere in quello che fa e superare le disobbedienze procedurali della bestia.
“Trico’s AI was one of the biggest challenges for us. For example, when the boy calls Trico, we could have made Trico come immediately, like clockwork. But if we did that, Trico would not seem like an independent creature. It wouldn’t seem like it was alive and making its own decisions…But at the same time, if it takes too long for Trico to come, that could stress the player.” Cit. Ueda.
Le disobbedienze random sono state volute da Ueda. Alcuni sostengono però che i ritardi della bestia siano la conseguenza di falle nell’IA. A mio avviso la ragione sta da entrambe le parti, nel senso che, visti i ritardi nello sviluppo del gioco, e visto che si è sempre parlato di difficoltà in corso d’opera per rendere Trico credibile, non c’è motivo per dubitare che Ueda abbia davvero voluto un’IA con pretese di verosomiglianza, che emulasse quindi anche i lati più fastidiosi dell’avere a che fare con un animale aggressivo e poco accondiscendente.
D’altra parte è difficile credere che, in una base che funziona spesso as intended, qui e lì non venga fuori anche qualche reazione unintened.
Insomma, è plausibile che l’IA qualche volta fallisca, ma il punto è: ne siamo consapevoli?
Se il prestigio funziona, c’è davvero bisogna di sapere cosa sta facendo il prestigiatore?
Perché non so voi, ma alle mie sollecitazioni Trico non ha mai risposto con totale indifferenza. Si grattava, sbraitava, alzava la testolina, mi fissava, qui e lì inumidiva gli occhioni. Insomma, io non ho mai visto un robot con un’IA che ora funziona e ora si spegne, ho sempre visto, semplicemente, l’accurata riproduzione di un animale.
Ad ogni modo, questa impostazione di base comporta per forza di cose larghe fette di passività, ossia momenti in cui osserviamo le reazioni, i salti e le manovre di allineamento di Trico, riducendoci al ruolo di spalla spettatrice. Questo comporta un ritmo obiettivamente lento. Badate, la costruzione non è per forza sgradevole, e comunque fa leva su di una dose di stupefazione senz’altro maggiore che nei momenti in cui mille altri giochi mettono in pausa il gameplay per ammorbare con l’ennesima cutscene diretta male e scritta peggio, ma si tratta semplicemente ed obiettivamente di un ritmo lento, avvallato da un level design che nelle prime battute non è generoso di trovate e si adagia piuttosto su semplici puzzle rooms pensate per far sì che il giocatore abbia modo di familiarizzare con le gestione di Trico.
Poi qualcosa cambia.
Che abbiate sperimentato o meno con le gestures previste, il gioco, a mezzo delle solite schermate hint a schermo, ve le suggerisce, iniziandovi al loro uso, perché da quel momento in poi si renderanno strumento indispensabile e non più solo un modo facoltativo per accelerare l’operato di Trico.
E’ un modo attraverso cui il game design spinge verso una crescita del rapporto interattivo tra il bambino e Trico e, da quel momento in poi, il crescendo relazionale e situazionale si fa sempre più consistente.
Si ha a che fare con setpieces sempre più strabilianti; con un climbing vertiginoso che non viene a patti con il context sensitive, preferendo sempre la coerenza di fisica e collisioni; e ancora con l’abbattimento degli specchi e di altri ostacoli ambientali; con nemici; con situazioni concitate in cui tanta roba crolla e ancora con puzzles non ostici ma geniali nell’allestimento e appaganti nella risoluzione. Fino al punto in cui il level design mescola e rimescola queste tessere, creando situazioni in cui le problematiche da risolvere sinora elencate risultano sempre più contemporanee e concomitanti, rendendo serrata la collaborazione con Trico, il quale si scopre un perfetto partner.
Certo, a patto di stare giocando bene.
In ogni caso il gioco non è punitivo. Il game over non è mai un avvenimento ricorrente. Il game design fa il possibile per snellire (si riparte sempre dalla stanza dove si è morti, se si cade durante un salto si riparte da una manciata di passi prima, alla stregua di un Uncharted) e anche per instradare il rafforzamento del rapporto interattivo con Trico. Infatti, mano a mano che si superano certi momenti topici del racconto, Trico diventa sempre più collaborativo, i suoi tempi di reazione si accorciano enormemente, e spesso potrebbe persino essere lui a suggerire voi il percorso (a me è capitato sin dal primo terzo dell’avventura, e da lì via via a crescere), anziché il contrario.
Ho riscontrato una sola grave occasione in cui il gioco mi è sembrato rompersi, perché la plausibilità della fisica e il posizionamento del tutto occasionale di un punto di appiglio mi hanno reso reso oggettivamente improbabile il prosieguo. Mi riferisco alla famigerata grotta inondata di acqua con le travi soprastanti. Non so se da allora abbiano patchato rendendo più scriptata la faccenda, di modo da non ostruire in maniera ingiusta il prosieguo. Verificherò nella prossima giocata. Tra le mille cose che Breath of the Wild ci ricorda, c’è che a tratti è giusto rinunciare ad un po’ di coerenza, rendendo physics-free qualche elemento che in altre circostanze sarebbe stato gestito dalla fisica, di modo da non rompere o rendere poco gestibile il prosieguo.
Si tratta comunque dell’unico (francamente stucchevole) episodio.
Neanche sto a commentare eccessivamente la costruzione architettonica, il vertiginoso sviluppo verticale, e l’art design tutto che contraddistingue il Nido, l’ambientazione in cui si svolge il gioco. La scala è colossale, la costruzione coerente e perciò immersiva, in quanto come in Ico il giocatore ha sempre contezza della sua collocazione nella spazio-gioco e nella scalata verso la libertà.
A livello di art direction è un apice del videogioco. Senza se e né ma.
Semplicemente non esiste un ambientazione nel panorama tutto che si cimenti in questo tipo di rappresentazione avvicinando questi stessi risultati.
Non mi dilungo perché se non avete percepito con la fruizione diretta la straordinarietà del lavoro fatto sul concepimento e l’allestimento del Nido, non saranno di certo le mie parole a restituire siffatta percezione.
Di assoluto pregio e puntualità anche il lavoro su OST e sound design, anche se magari più nell’ordinario rispetto al lavoro di estetica. Certo, la maniera con cui taluni brani vengono posizionati rispetto a certi momenti di gioco, creando una vera e propria catarsi, resta ragguardevole e non di comune riscontro.
Insomma, iniziando a tirare un po’ le fila del discorso, quello di The Last Guardian è secondo me un game design abbastanza elegante e raffinato, attento a costruire e collocare ogni elemento della produzione in modo da spingere al massimo su quello che il gioco si propone di raccontare e far vivere sulla pelle del fruitore.
E’ un game design che si propone un obiettivo molto specifico, per cui difficilmente può godere di universale apprezzamento. Non è praticamente possibile che possa sentirsi a suo agio con The Last Guardian chi predilige una delle categorie videoludiche richiamate nella introduzione di questa disamina ma ne disprezza un’altra un po’ antitetica; e non è soltanto un fatto di settorializzazione dell’offerta, si tratta bensì della maniera estremamente decostruzionista con cui l’opera incorpora elementi come la “passività” e il “ritardo occasionale della reazione alle azioni del giocatore”, elementi che per definizione sono antitetici rispetto ad una concezione più classicista, dogmatica, prestazionale e conservatrice del videogioco.
Inoltre parliamo di un game design che non sempre si esprime al meglio del potenziale e che non cerca praticamente mai l’accondiscendenza di un certo pubblico, dal momento che neppure prova a mitigare certe condizioni di disagio nel rapporto bimbo-Trico con idee concomitanti di universale apprezzabilità sul piano dell’efficacia intrattenitiva.
Non bastasse, ci stanno almeno due problematiche tecniche che sporcano il tradursi a schermo in gameplay del discusso game design:
1) La programmazione della telecamera è senza mezzi termini inadeguata in molti casi, rea di compromettere il potere immaginifico che il disvelamento di certe vedute dovrebbe esercitare sul giocatore, nonché di rendere più difficoltose e legnose le manovre preparatorie di taluni salti. Certo, data la natura del gioco, non è una telecamera criminale, di fatto game breaking, come quella di Bloodborne o di un Ninja Gaiden Xbox prima versione. Non c’è prestazione esigente che rischia di essere compromessa. Non c’è il rischiare di morire e dover ripetere un intero segmento di livello, per ritornare lì, dove si era morti, col rischio che la camera faccia qualche altro brutto scherzo.
2) Il frame rate è disprezzabile ma, anche in questo caso, vista la natura dell’opera, rompe più l’immersione del momento che il gameplay. Non è comunque accettabile, intendiamoci, ma la situazione è ben più rosea rispetto alla prima release di Shadow of the Colossus, su PS2, dove non solo si giocava quasi costantemente a 20fps e meno, ma il frame rate comprometteva tanto l’immersione quanto l'utilizzo delle meccaniche, visto che il clamoroso input lag e la scattosità delle immagini potevano determinare il fallimento di un salto, con la conseguenza di dover ricominciare la scalata al Colosso o, in caso di morte, addirittura lo scontro intero. Ci si abituava; il gioco non era anche in quel caso troppo esigente o punitivo, ma era comunque tanto soffrire, molto, molto di più che in The Last Guardian oggi.
Eppure, tirando definitivamente le somme, The Last Guardian rimane un esempio di game design interessante e non banale, per non dire unico, praticamente dall’inizio alla fine (con la sola eccezione già illustrata della caverna acquatica).
Proprio con riferimento alla “fine” del viaggio, ricordo i banali pronostici di noi giocatori: un 50% scommetteva sulla morte del bimbo, l’altro 50% su quella di Trico. Ma Ueda, si sa, non è un tipo banale.
Tanto il cosa quanto il come risultano orchestrati in maniera magistrale, trovando nella “non accettazione del diverso” un naturale punto di approdo, quella stessa “non accettazione del diverso” che era stato il presupposto dell’esilio di Ico e che aveva gettato le basi per quel primo viaggio alla ricerca dell’instaurazione di un legame e della libertà.
Si tratta di una chiusura circolare del percorso tematico spalmato da Ueda su tre giochi assolutamente encomiabile.
Insomma, concludendo, non si tratta di un’opera perfetta e conciliante ma, semplicemente, non esiste un gioco che racconta ed inscena a mezzo dell’interazione, fino al più viscerale moto di gioia, dolcezza, esaltazione e finanche frustrazione e dolore quello che racconta ed inscena The Last Guardian come lo racconta ed inscena The Last Guardian. Questo risultato credo dia dignità al medium videogioco più di quanto lo dia qualsiasi forma di accanimento terapeutico verso la ricerca della perfezione formale.
Apprezzerei si iniziasse a ragionare sui giochi più in termini di significatività dell’opera nel complessivo, in termini di sforzo creativo e perizia esecutiva nell’edificare una certa visione, in grado in qualche modo di valorizzare le peculiarità del medium. Questo non significa rinunciare al rigore analitico, semplicemente si tratta di evitare di trattare i VG come prodotti da supermercato da pesare in maniera asettica su una bilancia pro e contro, un tanto al chilo. Senza voler con questo negare e neppure giustificare in alcun modo le storture di The Last Guardian e la loro rilevanza.
In definitiva, se dovessi esprimere un voto, credo sarebbe si attesterebbe in zona 8,5. Per cui, a fronte di un metascore pari a 83, direi equamente valutato. Mi fa accapponare la pelle il fatto che alcuni titoli, francamente avvilenti tanto per il genere di riferimento quanto per la crescita del medium stesso, abbiano più di TLG. Ma non è TGL ad essere sottovalutato, sono semmai quegli altri lavori ad essere stati sopravvalutati. Ma questa è un’altra storia.



 sicuramente mi avete fatto venir voglia di una nuova run
sicuramente mi avete fatto venir voglia di una nuova run