Fusenr
Professionista
- Iscritto dal
- 3 Apr 2013
- Messaggi
- 7,338
- Reazioni
- 2,110
Offline
Riporto direttamente l'articolo che mi sembra adatto a fornire un input alla discussione.
Premessa.
Nell’articolo ci soffermeremo a riflettere su alcuni testi videoludici appartenenti a un medesimo genere di riferimento – il survival horror. Con questa breve premessa, a grandi linee e con la dovuta flessibilità, cerchiamo di tratteggiarne i motivi di interesse nonché qualche caratteristica fondamentale.
Come categoria dialettica quella del survival horror1 circoscrive un insieme basato su alcuni elementi ricorrenti: un’atmosfera ricca di tensione, la presenza di una minaccia terrificante, un numero limitato di risorse e una serie di enigmi da risolvere. Dal punto di vista narrativo, i titoli che appartengono al genere presuppongono l’isolamento di un protagonista cinto d’assedio dalle forze del male in un luogo misterioso e oscuro. Da quello iconografico rimandano a un cosmo di riferimenti di inevitabile matrice filmica: morti viventi, mostri deformi e altre aberrazioni abitano atmosfere desunte da un immaginario popolare già filtrato e magnificato da grandi e piccoli schermi. È proprio l’isolamento a mettere però in discussione la collettività esperienziale2 della sala cinematografica, fonte d’ispirazione primaria dei mondi possibili del videogioco horror, oltre a fornirci il primo e più ricorrente elemento strutturale alla nostra analisi.
Come scrive Jean-Sébastien Chauvin i survival horror sono esperienze finzionali personali, “segrete”, che l’utente è chiamato a vivere in uno stato di solitudine – magari immerso nell’oscurità, come riecheggia il titolo di uno dei capisaldi del genere [Alone in the Dark, (id., Infogrames, 1992)]. «L’esperienza solitaria del personaggio specchia quella del giocatore»,3 il quale si trova in ambienti e racconti terrificanti nel medesimo stato in cui vi si immerge il suo avatar. Ecco che pur recuperando (ma evolvendo) un immaginario strettamente filmico il videogioco diventa «quintessenza di quest’era di solitudine»,4 consentendo all’utente di fare esperienza diretta di un racconto in cui interpreti e sia, a tutti gli effetti, «l’ultimo uomo sulla terra».5 A patto che voglia stare al gioco, il fruitore si troverà dinnanzi a immagini ben diverse da quelle cinematografiche: mondi permeabili in grado di imporre al reale una propria sfera d’influenza, tale da farlo diventare estensione stessa del virtuale. È forse questa natura immersiva ed emotivamente prorompente ad aver contribuito allo sconfinato successo che i survival horror hanno avuto nel tempo, nonché a portare uno dei più influenti esperti in materia, Bernard Perron, a definirli come «il genere videoludico per eccellenza».6 Trovandosi in un interspazio indefinito in cui l’atmosfera dello schermo viene estesa al di là dei propri limiti fisici,7 l’utente del survival horror mette in comunicazione realtà alternative: l’abisso nero come la pece che il suo personaggio esplora e l’oscurità che circonda lo schermo, la solitudine del suo avatar e la sua, l’angosciosa sensazione di essere spiato e braccato nel mondo finzionale e quella di esserlo, contro ogni aspettativa, anche nello spazio reale. Più di altri videogiochi quelli ascritti al genere survival horror negoziano con la realtà un terreno di scambio inedito, terrificante – il più delle volte interiore, inerente cioè esperienze private del giocatore.
Nel corso dell’articolo rifletteremo su alcune modalità di negoziazione tra spazio virtuale e spazio reale in atto nel videogioco horror: ci interesserà in particolare porre in risalto alcuni processi di natura iconologica, narrativa e interattiva in grado di estendere e ridefinire l’ambiente digitale al di là dei propri confini – di fatto, favorendo nel fruitore l’esperienza di terrore o di angoscia al centro della testualità in esame.
I testi che considereremo non apparterranno alla contemporaneità videoludica, saranno piuttosto episodi “storici” (per lo più compresi nell’arco temporale 1990-2005) che ne hanno definito lo sviluppo: questo per esigenze di chiarezza e circoscrizione della nostra zona d’interesse.
Oltre l’interdizione dello sguardo – iterazioni del fuori campo.
Possiamo rinvenire una prima di queste negoziazioni nelle modalità stesse in cui l’ambiente digitale viene a strutturarsi durante la partita.8
Nel notare come gli angoli di ripresa9 siano fonte primaria della costruzione della tensione del survival horror Perron10 accenna al rilievo che assume il fuori campo nella configurazione dello spazio di gioco. Le matrice filmica di questo processo è evidente: la distinzione tra campo e fuori campo polarizza le inquadrature del videogioco dando allo spazio della visione (che è anche spazio dell’azione) uno statuto preciso. La scomposizione dei luoghi passa così per il filtro drammatizzante e narrativo della camera digitale: ciò è più evidente che mai nei survival horror a inquadratura fissa. Un primo esempio lo troviamo nelle fasi iniziali di uno dei titoli più celebri del genere: Resident Evil 2 [Biohazard 2, Capcom, 1998]. Qui il protagonista entra in un negozio traendosi in salvo dall’apocalisse zombie che imperversa per le strade: l’angolo di ripresa ce lo presenta a figura intera e con lo sguardo rivolto verso la camera, spalle all’ingresso che si è appena lasciato dietro. L’utente è libero di muovere un passo in avanti, al che una voce lo immobilizza intimandogli di restare fermo dov’è e dando avvio a una breve sequenza animata. Si viene a scoprire dall’inquadratura successiva che un negoziante in stato d’allarme stava puntando il fucile dritto verso il protagonista.
Il fuori campo in questa sequenza è determinante: nella prima inquadratura, il giocatore ha uno spazio di visione e d’azione così ristretto da sentirsi preda degli eventi – attorno al suo protagonista potrebbe celarsi qualsiasi minaccia. Nel momento in cui la voce del negoziante spezza il silenzio, poi, tutto il senso della scena fugge verso i confini del quadro e annulla l’immagine nel campo che la segue, più largo e sinottico. La latenza del pericolo si sostanzia in un fuori campo opprimente, angoscioso e pronto da un momento all’altro a vampirizzare il quadro. Un esempio paradigmatico e che riassume efficacemente l’importanza del fuori campo nel genere. Rimanendo nel dominio delle inquadrature fisse, innumerevoli sono i casi di avversari mostruosi che irrompono direttamente a partire da un ambiente né visibile né agibile: quello seminale è probabilmente il mostro che sfonda la finestra nella primissima sezione di Alone in the Dark, riproposto più volte dalle serie Resident Evil [Biohazard, Capcom, 1996 – in corso] tanto da diventare un vero e proprio topos del survival horror. Il motivo è subito comprensibile: nulla rende l’utente più insicuro e spaventato della possibilità che qualcosa di invisibile all’improvviso diventi visibile.Ecco che il survival horror inizia a ruotare attorno a un’idea dello spazio dominata dal dubbio e dall’insicurezza, fondata per lo più sulla possibilità che al di là delle soglie d’interdizione dello sguardo si nasconda qualcosa di terribile e pronto ad affiorare all’interno del quadro. Dietro ogni angolo può nascondersi un morto vivente, ogni finestra può cadere in mille frantumi e far apparire la bestia.
Siamo oltre la distinzione tra luogo e spazio di cui scrivono Mary Fuller e Henry Jenkins a proposito dei titoli strategici:11 non si ha a che fare con un ambiente astratto che inizia a esistere in concreto ed estende qualcosa di già presente e agibile, piuttosto con un altrove proibito (e che rimane tale) dal quale il pericolo emerge direttamente. Il risultato è un mondo che non si può abitare con sicurezza. Questo senso di vulnerabilità nasce da una contrapposizione interno/esterno che viene istituita in prima istanza dalla polarità campo/fuori-campo di cui si è parlato poco sopra: si presuppone che una zona d’influenza diretta (dello sguardo, del gesto) venga continuamente assediata da una invece impossibile, vietata, in cui lo sguardo e il gesto non sono neanche pensabili. La distinzione risulta evidente nelle varie inquadrature che ci mostrano la soggettiva del mostro, della minaccia in agguato: qui il quadro viene definito da un fuori campo che si determina, a scanso di equivoci, come primo dominio di incertezza e terrore.
A livello diegetico la contrapposizione viene ribadita all’infinito: gli spazi del survival horror sono regolarmente circondati dal buio, costellati di soglie oltre le quali non si può andare, al di là di cui non si vede nulla, in cui è troppo pericoloso o difficile addentrarsi. Una serie di interdizioni sostanziali.
L’unico modo per contrastare l’insicurezza dello spazio riflette la staticità architettonica e visiva del survival horror a inquadratura fissa: consiste cioè nella delimitazione e protezione delle barriere che definiscono i luoghi dell’azione. Chiudere una saracinesca diventa obbiettivo di primaria importanza, abbandonare in fretta un corridoio con delle finestre (integre o in frantumi che siano)13 una necessità. Dalle feritoie, dai buchi, dalle finestre o dalle pareti può fare ingresso qualsiasi orrore: animali deformi, morti viventi, spettri armati di gigantesche forbici14 e così via. Quando lo spazio non si può delimitare o proteggere l’utente resta in balia di angoscia e paranoia. È il caso della serie Project Zero [Zero, Tecmo, 2001-05], in cui i fantasmi affiorano in qualsiasi momento dai muri, dal soffitto o dal terreno trasformando l’ambiente in un’impalcatura traslucida e permeabile, inadatta a fornire qualsiasi forma di protezione.
Campo e fuori campo, interno ed esterno: l’horror videoludico rimodella l’attenzione sullo spazio dell’orrore letterario o cinematografico, in particolare partendo dalla rappresentazione ossessiva e centralizzante di uno spazio chiuso15 che ritorni a livello visivo quanto architettonico. È in questi spazi che qualcosa d’improvviso si manifesta al posto del nulla, rievocando quel “perturbante” di cui scrive anche Schelling nella sua Filosofia della mitologia.16 «[…] Il vero orrore è quello di Qualcosa […] laddove ci aspetteremmo il Nulla.»17
Articolo completo dove oltretutto potete visionare alcune immagini di riferimento e relative didascalie, come pure le note a margine, che per pura e semplice comodità ho omesso nel trasferimento da una sede all'altra. Se volete leggerlo tutto vi avviso che da un certo punto in poi credo arrivino grossi spoiler di titoli che i più conosceranno meglio di me. Io mi sono fermato a leggere in quel punto.
Comunque i crediti per quanto ivi riportato vanno tutti all'autore dell'articolo, io ho estrapolato soltanto la prima parte, cioè quella che mi interessava maggiormente allo scopo di introdurre l'argomento preso in esame, senza operare alcun tipo di rimaneggiamento del materiale originario.
Intanto, siete d'accordo con quanto scritto nell'articolo?
Poi, addentrandoci concretamente nella questione, in una generazione in cui sono fioccati open world che, con la loro proclamata libertà di esplorazione, potrebbero essere presi a simbolo di una rinuncia al controllo autoriale delle informazioni visive durante l'azione in tempo reale, pensate che la telecamera fissa nel genere survival horror sia uno strumento di espressione ormai arcaico e obsoleto, oppure che sotto la sapiente supervisione di autori talentuosi abbia ancora qualcosa da dire o, addirittura, che non sia mai veramente invecchiata perdendo la sua efficacia bensì sia stata soltanto abbandonata?
E le schermate fisse che scandivano riquadri precisi negli adventure platform ad enigmi ambientali e progressione bidimensionale come i primi due capitoli della serie Oddworld?
O Yoko Taro che, con i due NieR, in controtendenza rispetto ai generi a cui potrebbero essere ricondotti questi prodotti, ha cercato di riappropriarsi dei confini del flusso audiovisivo forzando la prospettiva dell'inquadratura in svariate sezioni di gioco?
Premessa.
Nell’articolo ci soffermeremo a riflettere su alcuni testi videoludici appartenenti a un medesimo genere di riferimento – il survival horror. Con questa breve premessa, a grandi linee e con la dovuta flessibilità, cerchiamo di tratteggiarne i motivi di interesse nonché qualche caratteristica fondamentale.
Come categoria dialettica quella del survival horror1 circoscrive un insieme basato su alcuni elementi ricorrenti: un’atmosfera ricca di tensione, la presenza di una minaccia terrificante, un numero limitato di risorse e una serie di enigmi da risolvere. Dal punto di vista narrativo, i titoli che appartengono al genere presuppongono l’isolamento di un protagonista cinto d’assedio dalle forze del male in un luogo misterioso e oscuro. Da quello iconografico rimandano a un cosmo di riferimenti di inevitabile matrice filmica: morti viventi, mostri deformi e altre aberrazioni abitano atmosfere desunte da un immaginario popolare già filtrato e magnificato da grandi e piccoli schermi. È proprio l’isolamento a mettere però in discussione la collettività esperienziale2 della sala cinematografica, fonte d’ispirazione primaria dei mondi possibili del videogioco horror, oltre a fornirci il primo e più ricorrente elemento strutturale alla nostra analisi.
Come scrive Jean-Sébastien Chauvin i survival horror sono esperienze finzionali personali, “segrete”, che l’utente è chiamato a vivere in uno stato di solitudine – magari immerso nell’oscurità, come riecheggia il titolo di uno dei capisaldi del genere [Alone in the Dark, (id., Infogrames, 1992)]. «L’esperienza solitaria del personaggio specchia quella del giocatore»,3 il quale si trova in ambienti e racconti terrificanti nel medesimo stato in cui vi si immerge il suo avatar. Ecco che pur recuperando (ma evolvendo) un immaginario strettamente filmico il videogioco diventa «quintessenza di quest’era di solitudine»,4 consentendo all’utente di fare esperienza diretta di un racconto in cui interpreti e sia, a tutti gli effetti, «l’ultimo uomo sulla terra».5 A patto che voglia stare al gioco, il fruitore si troverà dinnanzi a immagini ben diverse da quelle cinematografiche: mondi permeabili in grado di imporre al reale una propria sfera d’influenza, tale da farlo diventare estensione stessa del virtuale. È forse questa natura immersiva ed emotivamente prorompente ad aver contribuito allo sconfinato successo che i survival horror hanno avuto nel tempo, nonché a portare uno dei più influenti esperti in materia, Bernard Perron, a definirli come «il genere videoludico per eccellenza».6 Trovandosi in un interspazio indefinito in cui l’atmosfera dello schermo viene estesa al di là dei propri limiti fisici,7 l’utente del survival horror mette in comunicazione realtà alternative: l’abisso nero come la pece che il suo personaggio esplora e l’oscurità che circonda lo schermo, la solitudine del suo avatar e la sua, l’angosciosa sensazione di essere spiato e braccato nel mondo finzionale e quella di esserlo, contro ogni aspettativa, anche nello spazio reale. Più di altri videogiochi quelli ascritti al genere survival horror negoziano con la realtà un terreno di scambio inedito, terrificante – il più delle volte interiore, inerente cioè esperienze private del giocatore.
Nel corso dell’articolo rifletteremo su alcune modalità di negoziazione tra spazio virtuale e spazio reale in atto nel videogioco horror: ci interesserà in particolare porre in risalto alcuni processi di natura iconologica, narrativa e interattiva in grado di estendere e ridefinire l’ambiente digitale al di là dei propri confini – di fatto, favorendo nel fruitore l’esperienza di terrore o di angoscia al centro della testualità in esame.
I testi che considereremo non apparterranno alla contemporaneità videoludica, saranno piuttosto episodi “storici” (per lo più compresi nell’arco temporale 1990-2005) che ne hanno definito lo sviluppo: questo per esigenze di chiarezza e circoscrizione della nostra zona d’interesse.
Oltre l’interdizione dello sguardo – iterazioni del fuori campo.
Possiamo rinvenire una prima di queste negoziazioni nelle modalità stesse in cui l’ambiente digitale viene a strutturarsi durante la partita.8
Nel notare come gli angoli di ripresa9 siano fonte primaria della costruzione della tensione del survival horror Perron10 accenna al rilievo che assume il fuori campo nella configurazione dello spazio di gioco. Le matrice filmica di questo processo è evidente: la distinzione tra campo e fuori campo polarizza le inquadrature del videogioco dando allo spazio della visione (che è anche spazio dell’azione) uno statuto preciso. La scomposizione dei luoghi passa così per il filtro drammatizzante e narrativo della camera digitale: ciò è più evidente che mai nei survival horror a inquadratura fissa. Un primo esempio lo troviamo nelle fasi iniziali di uno dei titoli più celebri del genere: Resident Evil 2 [Biohazard 2, Capcom, 1998]. Qui il protagonista entra in un negozio traendosi in salvo dall’apocalisse zombie che imperversa per le strade: l’angolo di ripresa ce lo presenta a figura intera e con lo sguardo rivolto verso la camera, spalle all’ingresso che si è appena lasciato dietro. L’utente è libero di muovere un passo in avanti, al che una voce lo immobilizza intimandogli di restare fermo dov’è e dando avvio a una breve sequenza animata. Si viene a scoprire dall’inquadratura successiva che un negoziante in stato d’allarme stava puntando il fucile dritto verso il protagonista.
Il fuori campo in questa sequenza è determinante: nella prima inquadratura, il giocatore ha uno spazio di visione e d’azione così ristretto da sentirsi preda degli eventi – attorno al suo protagonista potrebbe celarsi qualsiasi minaccia. Nel momento in cui la voce del negoziante spezza il silenzio, poi, tutto il senso della scena fugge verso i confini del quadro e annulla l’immagine nel campo che la segue, più largo e sinottico. La latenza del pericolo si sostanzia in un fuori campo opprimente, angoscioso e pronto da un momento all’altro a vampirizzare il quadro. Un esempio paradigmatico e che riassume efficacemente l’importanza del fuori campo nel genere. Rimanendo nel dominio delle inquadrature fisse, innumerevoli sono i casi di avversari mostruosi che irrompono direttamente a partire da un ambiente né visibile né agibile: quello seminale è probabilmente il mostro che sfonda la finestra nella primissima sezione di Alone in the Dark, riproposto più volte dalle serie Resident Evil [Biohazard, Capcom, 1996 – in corso] tanto da diventare un vero e proprio topos del survival horror. Il motivo è subito comprensibile: nulla rende l’utente più insicuro e spaventato della possibilità che qualcosa di invisibile all’improvviso diventi visibile.Ecco che il survival horror inizia a ruotare attorno a un’idea dello spazio dominata dal dubbio e dall’insicurezza, fondata per lo più sulla possibilità che al di là delle soglie d’interdizione dello sguardo si nasconda qualcosa di terribile e pronto ad affiorare all’interno del quadro. Dietro ogni angolo può nascondersi un morto vivente, ogni finestra può cadere in mille frantumi e far apparire la bestia.
Siamo oltre la distinzione tra luogo e spazio di cui scrivono Mary Fuller e Henry Jenkins a proposito dei titoli strategici:11 non si ha a che fare con un ambiente astratto che inizia a esistere in concreto ed estende qualcosa di già presente e agibile, piuttosto con un altrove proibito (e che rimane tale) dal quale il pericolo emerge direttamente. Il risultato è un mondo che non si può abitare con sicurezza. Questo senso di vulnerabilità nasce da una contrapposizione interno/esterno che viene istituita in prima istanza dalla polarità campo/fuori-campo di cui si è parlato poco sopra: si presuppone che una zona d’influenza diretta (dello sguardo, del gesto) venga continuamente assediata da una invece impossibile, vietata, in cui lo sguardo e il gesto non sono neanche pensabili. La distinzione risulta evidente nelle varie inquadrature che ci mostrano la soggettiva del mostro, della minaccia in agguato: qui il quadro viene definito da un fuori campo che si determina, a scanso di equivoci, come primo dominio di incertezza e terrore.
A livello diegetico la contrapposizione viene ribadita all’infinito: gli spazi del survival horror sono regolarmente circondati dal buio, costellati di soglie oltre le quali non si può andare, al di là di cui non si vede nulla, in cui è troppo pericoloso o difficile addentrarsi. Una serie di interdizioni sostanziali.
L’unico modo per contrastare l’insicurezza dello spazio riflette la staticità architettonica e visiva del survival horror a inquadratura fissa: consiste cioè nella delimitazione e protezione delle barriere che definiscono i luoghi dell’azione. Chiudere una saracinesca diventa obbiettivo di primaria importanza, abbandonare in fretta un corridoio con delle finestre (integre o in frantumi che siano)13 una necessità. Dalle feritoie, dai buchi, dalle finestre o dalle pareti può fare ingresso qualsiasi orrore: animali deformi, morti viventi, spettri armati di gigantesche forbici14 e così via. Quando lo spazio non si può delimitare o proteggere l’utente resta in balia di angoscia e paranoia. È il caso della serie Project Zero [Zero, Tecmo, 2001-05], in cui i fantasmi affiorano in qualsiasi momento dai muri, dal soffitto o dal terreno trasformando l’ambiente in un’impalcatura traslucida e permeabile, inadatta a fornire qualsiasi forma di protezione.
Campo e fuori campo, interno ed esterno: l’horror videoludico rimodella l’attenzione sullo spazio dell’orrore letterario o cinematografico, in particolare partendo dalla rappresentazione ossessiva e centralizzante di uno spazio chiuso15 che ritorni a livello visivo quanto architettonico. È in questi spazi che qualcosa d’improvviso si manifesta al posto del nulla, rievocando quel “perturbante” di cui scrive anche Schelling nella sua Filosofia della mitologia.16 «[…] Il vero orrore è quello di Qualcosa […] laddove ci aspetteremmo il Nulla.»17
Articolo completo dove oltretutto potete visionare alcune immagini di riferimento e relative didascalie, come pure le note a margine, che per pura e semplice comodità ho omesso nel trasferimento da una sede all'altra. Se volete leggerlo tutto vi avviso che da un certo punto in poi credo arrivino grossi spoiler di titoli che i più conosceranno meglio di me. Io mi sono fermato a leggere in quel punto.
Comunque i crediti per quanto ivi riportato vanno tutti all'autore dell'articolo, io ho estrapolato soltanto la prima parte, cioè quella che mi interessava maggiormente allo scopo di introdurre l'argomento preso in esame, senza operare alcun tipo di rimaneggiamento del materiale originario.
Intanto, siete d'accordo con quanto scritto nell'articolo?
Poi, addentrandoci concretamente nella questione, in una generazione in cui sono fioccati open world che, con la loro proclamata libertà di esplorazione, potrebbero essere presi a simbolo di una rinuncia al controllo autoriale delle informazioni visive durante l'azione in tempo reale, pensate che la telecamera fissa nel genere survival horror sia uno strumento di espressione ormai arcaico e obsoleto, oppure che sotto la sapiente supervisione di autori talentuosi abbia ancora qualcosa da dire o, addirittura, che non sia mai veramente invecchiata perdendo la sua efficacia bensì sia stata soltanto abbandonata?
E le schermate fisse che scandivano riquadri precisi negli adventure platform ad enigmi ambientali e progressione bidimensionale come i primi due capitoli della serie Oddworld?
O Yoko Taro che, con i due NieR, in controtendenza rispetto ai generi a cui potrebbero essere ricondotti questi prodotti, ha cercato di riappropriarsi dei confini del flusso audiovisivo forzando la prospettiva dell'inquadratura in svariate sezioni di gioco?
Ultima modifica da un moderatore:

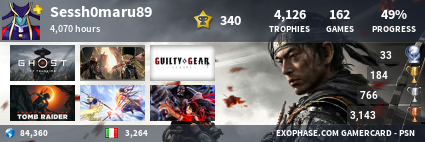
 ), ma in effetti è interessante riflettere sul fatto che l'immersività nell'horror può essere data dal senso di solitudine e dall'atmosfera, molto più che dalla telecamera.
), ma in effetti è interessante riflettere sul fatto che l'immersività nell'horror può essere data dal senso di solitudine e dall'atmosfera, molto più che dalla telecamera. ) le vostre impressioni (nel senso più generale
) le vostre impressioni (nel senso più generale 

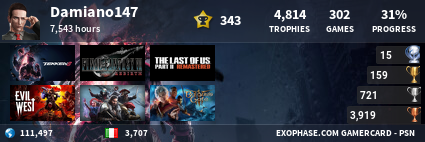
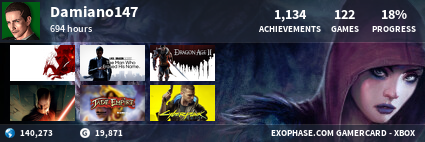




 se c'è qualcosa che è stato veramente inquietante direi La Signora...la parte di gioco che le è dedicata è molto breve, e anche le fasi di fuga, ma quella volta che le si deve sfuggire è da ansie nere
se c'è qualcosa che è stato veramente inquietante direi La Signora...la parte di gioco che le è dedicata è molto breve, e anche le fasi di fuga, ma quella volta che le si deve sfuggire è da ansie nere  quindi ormai aspetterò.
quindi ormai aspetterò.
 anche se pure il finale non scherza.
anche se pure il finale non scherza.
