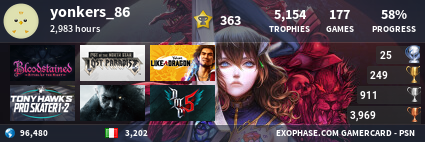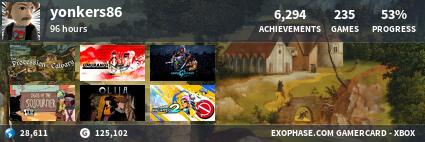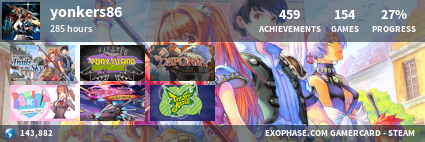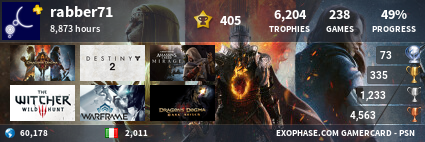L’italiano: una lingua gendered. Nel caso delle lingue romanze come l’italiano, il binarismo di genere della società eteronormativa si riflette perfettamente nella declinazione di alcune parti variabili della frase (nomi, pronomi, aggettivi, participi passati) che prevede il genere maschile e quello femminile: a maggior ragione, proprio perché sembra riprodurre grammaticalmente la norma sociale, in italiano il genere è quello strumento grammaticale che «impone nel linguaggio un modo di essere nei sessi»10, cioè contribuisce alla normalizzazione/naturalizzazione del paradigma binario eteronormativo. Bisogna però considerare che ci sono lingue che non declinano i nomi e gli aggettivi secondo un genere grammaticale (come l’inglese, che tuttavia possiede i pronomi maschile e femminile alla terza persona singolare) o che ne prevedono più di due (come il tedesco, che possiede il neutro); d’altro canto, ci sono sistemi culturali11 che prevedono generi sessuali soprannumerari rispetto a uomo e donna12, e la cultura occidentale stessa oggi vive il dibattito sulla normalizzazione (cioè l’accettazione giuridica) di un terzo genere (agender) o quantomeno sulla possibilità di non vedersi assegnato un genere alla nascita sulla base delle caratteristiche genitali. La morfologia intende il genere grammaticale come sistema di classificazione formale, indipendente dal genere come categoria socioculturale: ne consegue che l’uso del maschile «neutro» nelle lingue sessuate (quelle che prevedono i generi grammaticali maschile e femminile) è inteso come «convenzione grammaticale»13. A partire dagli anni Settanta, la sociolinguistica femminista ha contestato la «neutralità» del plurale maschile e la scelta di usare il maschile per referenti femminili (come spesso per le professioni di prestigio), negandone la natura formale e affermandone quella socioculturale. L’equazione tra universale e maschile nasconde l’appropriazione da parte del maschile dell’universale, che fa sì che il genere maschile sia quello non marcato, mentre «esiste un solo genere», quello femminile. «La forma astratta, il generale, l’universale, questo è quello che sta a significare il cosiddetto genere maschile, in quanto la classe degli uomini si è appropriata dell’universale per sé stessa», scrive Wittig14 che ne Les Guérrillères tenta un’universalizzazione del plurale femminile elles, proprio per svelare – attraverso un processo di straniamento – l’artificiosità della pretesa naturalità del maschile «neutro».
 forum.spaziogames.it
forum.spaziogames.it