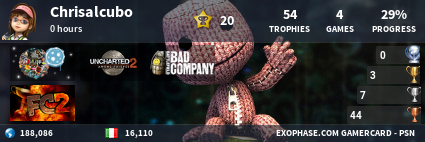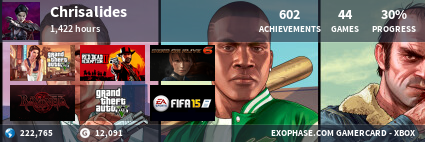L’Italia come unione monetaria
Nel 2006, uno studio della Banca d’Italia faceva osservare che 145 anni dopo l’unificazione monetaria dell’Italia (realizzata contemporaneamente all’unificazione politica), i livelli dei prezzi e i tassi d’inflazione nelle differenti regioni e province non convergevano ancora del tutto.
[vii] Un fenomeno molto intrigante. Infatti, stando alla teoria economica ortodossa, a determinare il livello dei prezzi è la quantità di moneta circolante. Sarebbe dunque logico attendersi che a una moneta unica corrisponda un livello di prezzi, o almeno un’inflazione, unici. Questo studio mostra che in Italia non va affatto così. Uno studio successivo mostrò che la medesima cosa succedeva su scala europea, dove si assiste a una divisione dei paesi in tre «club d’inflazione»: i paesi del Nord (che convergono verso un’ inflazione bassa), l’Italia (con un’inflazione media), e i paesi del Sud (con un’inflazione relativamente elevata).
[viii] L’esperienza delle regioni italiane suggerisce tuttavia che questo stato di fatto è destinato a persistere molto a lungo, il che significa che bisognerà attendere molto tempo perché tutti i paesi europei convergano verso il medesimo tasso di inflazione.
Da questi fatti statistici derivano due conseguenze significative.
In primo luogo, il fatto che una moneta unica conduca comunque a livelli di inflazione diversi rimette in discussione l’ingenua convinzione che sia la moneta che «causa» i livelli dei prezzi. Non si tratta di un’osservazione puramente teorica, al contrario: si tratta di una constatazione politica. L’inizio della terza globalizzazione (la globalizzazione «finanziaria») è stato caratterizzato da due importanti riforme istituzionali: la liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitali e l’affermazione del principio dell’indipendenza dai governi della Banca centrale.
[ix] Quest’ultimo si traduce nella proibizione rivolta alla Banca centrale di finanziare programmi di spesa pubblica attraverso l’emissione di moneta (incluso l’acquisto di titoli di debito pubblico al momento dell’emissione).
Questo divieto, giustificato all’epoca con la necessità di contenere l’inflazione legata all’impennata del prezzo del petrolio, ha avuto come conseguenza quella di obbligare gli Stati sovrani a rivolgersi ai mercati finanziari (e dunque in misura sempre crescente agli investitori internazionali) per soddisfare i loro bisogni di finanziamento. Si partiva dal principio che questo avrebbe sottoposto i governi, potenzialmente corrotti o miopi, alla disciplina dei mercati, visto che questi si sarebbero rifiutati di finanziare governi inefficienti.
Alla base di questo approccio, c’era l’idea che, poiché è la moneta che provoca l’inflazione, lasciando la gestione della massa monetaria nelle mani dei governi, questi ne avrebbero sicuramente approfittato a fini elettorali, provocando di conseguenza un aumento dell’inflazione.
Tuttavia, il fatto che da una parte una moneta unica possa coesistere con tassi di inflazione diversi e divergenti e dall’altra che la creazione massiccia di moneta da parte della BCE non sia riuscita a rianimare l’inflazione in Europa ci permette di vedere chiaramente che il legame tra massa monetaria e inflazione non è automatico. Questo spiega perché a una moneta unica non corrisponde un’inflazione unica. L’esperienza europea (e prima di questa l’esperienza italiana) ormai ci conferma che la dinamica dei prezzi è legata ad altri elementi strutturali di un sistema economico, in particolare al mercato del lavoro: è il tasso di disoccupazione, e non quello di creazione di moneta, che regola il tasso d’inflazione.
[x] Questo d’altra parte spiega perché è nel sud d’Italia, dove la disoccupazione è maggiore, che l’inflazione è più bassa. Se però la moneta non causa l’inflazione, non è più giustificabile la decisione di sottrarne la gestione ai governi per garantire la stabilità dei prezzi. Se cade questa motivazione, bisogna dunque che ci domandiamo quale sia la giustificazione per proibire il finanziamento monetario del debito pubblico. In effetti, l’idea di sottomettere gli Stati alla disciplina dei mercati o, in altri termini, di privatizzare il più possibile il circuito del risparmio e dell’investimento, sembra un po’ superata, in un periodo in cui si assiste alla crisi mondiale di questi stessi mercati.
Il fatto che una moneta unica non garantisca la convergenza dei tassi d’inflazione ha un’altra conseguenza importante. Se infatti non si produce una convergenza, la moneta unica non può garantire che il rapporto tra i prezzi dei beni prodotti all’interno di un paese e quelli prodotti all’estero, quello che si definisce il tasso di cambio «reale», sia stabile. Nei paesi dove l’inflazione è più bassa, questo rapporto avrà la tendenza a diminuire. Si assisterà così a quella che si definisce una svalutazione del tasso di cambio reale, che corrisponde a un miglioramento della competitività, e comporta un surplus commerciale, al quale dovrà necessariamente corrispondere un deficit da qualche altra parte (nei paesi dove l’inflazione è più alta). Se il paese più forte avesse la sua propria valuta, questa tendenza sarebbe compensata da una rivalutazione del suo tasso di cambio: la moneta del paese forte diventerebbe anch’essa più forte, perché tutti la richiederebbero per acquistare i beni che produce.
Ma se la moneta è unica, il paese più forte non può rivalutare, il che vale a dire che non può riallineare la sua moneta alla sua produttività. Il peso dell’aggiustamento sarà allora sostenuto dai paesi che, per svariate ragioni (storiche, tecnologiche, sociali, culturali) in quel momento sono meno produttivi.
Negli anni 80 c’era la tendenza a interpretare questi fenomeni in un’ottica moralistica. Il deficit commerciale, si diceva, spronerà i deboli a correggersi. Un eccesso persistente di importazioni crea necessariamente un debito estero (perché bisogna pagare i beni che si acquistano all’estero) e una perdita di posti di lavoro (perché le importazioni non creano lavoro nelle regioni di destinazione, ma in quelle di provenienza). I paesi deboli si troveranno dunque di fronte a un dilemma: o diventare più produttivi (in modo da poter avere prezzi meno elevati) o perdere posti di lavoro, e sceglieranno per forza di cose la strada giusta, cioè fare le riforme necessarie a diventare più produttivi.
L’idea secondo cui, una volta buttati nella piscina della moneta unica, i paesi più deboli avrebbero volenti o nolenti imparato a nuotare era di per sé piuttosto autoritaria e sorda allo spirito di «solidarietà» e «unione sempre più stretta» declamato dal progetto europeo. In più, era smentita dall’esperienza italiana, e anche dalla più recente esperienza tedesca, che dimostrava che le regioni più deboli non riescono a recuperare facilmente il loro ritardo, quando sono schiacciate dal peso di una moneta troppo forte.
[xi]
Infine, questa idea era un po’ ingenua, nel senso che è ingenuo illudersi che, in mancanza di una rivalutazione della valuta del paese forte, la riduzione dei prezzi nel paese debole possa sistemare le cose. Certo, in linea di principio per far scendere i prezzi basta essere più produttivi: se lo stesso lavoratore produce il doppio dei beni, i beni possono essere venduti a metà prezzo. Ma un aumento della produttività non si ottiene dall’oggi al domani. Questo meccanismo non è compatibile con l’urgenza generata dalle crisi finanziarie.
Quando scoppia la crisi, è piuttosto la disoccupazione (o la chiusura delle aziende) che assicura la moderazione dei prezzi. Se però la disoccupazione persiste, i lavoratori si trasferiscono. Per gli economisti «ortodossi» è un bene: il tasso di disoccupazione scende, perché, dopo che i disoccupati se ne sono andati, non ci sono più disoccupati. Pangloss non saprebbe dirlo meglio!
Gli economisti keynesiani hanno invece il buon senso di rendersi conto che questi disoccupati sono anche clienti delle aziende locali: la loro uscita di scena provoca quindi una crisi di domanda, che fa sprofondare le regioni deboli nella trappola del sottosviluppo. Se calano gli acquirenti locali, bisogna andare a caccia di mercati all’estero, e per farlo è necessario tagliare ancora maggiormente il costo del lavoro, ovvero i redditi dei lavoratori, spingendo ulteriormente a calare la domanda interna, in una spirale senza fine.
Del resto, è proprio questo che spiega la mancata convergenza dei prezzi tra le regioni italiane. La svalutazione «interna» (vale a dire la contrazione dei salari) è un meccanismo molto più lento e inerziale della svalutazione «esterna» (abbassamento del tasso di cambio della valuta nazionale). Una volta che il processo di aggiustamento è avviato, è difficile interromperlo al momento giusto, soprattutto se per favorirlo si sono messe in atto riforme strutturali (come il «jobs act» italiano o la «loi travail» francese). Il rischio è quindi di ritrovarsi intrappolati in una spirale deflazionistica. È quello a cui abbiamo assistito per decenni in Italia ed è quello da cui ci mette in guardia oggi la BCE a livello europeo.
Ci sono studi che dimostrano che la rigidità del tasso di cambio si accompagna a una crescita più debole.
[xii] Non c’è da stupirsene: quando il meccanismo di aggiustamento si basa sulla diminuzione dei salari, è necessario che aumenti la disoccupazione (perché in caso contrario i lavoratori non accetterebbero la riduzione dei loro redditi). Ma è il lavoro che crea il valore. Un sistema economico che si riequilibra attraverso la disoccupazione è dunque destinato a creare meno valore.
L’esperienza italiana ci mostra che in questo gioco nessuno è vincitore. Se le regioni del Nord per un certo periodo hanno potuto sfruttare quelle del Sud come fonte di manodopera a basso costo, e allo stesso tempo come mercato per i prodotti delle loro industrie, a lungo termine la divergenza tra le due parti del paese risulta un rischio per la crescita, che compromette la stabilità finanziaria e finisce col creare tensioni secessioniste (rappresentate in Italia dalla Lega Nord). Lo stesso scenario si presenta oggi su scala europea.
https://www.sinistrainrete.info/europa/8573-alberto-bagnai-unione-monetaria-un-punto-di-vista-italiano.html
 forum.spaziogames.it
forum.spaziogames.it